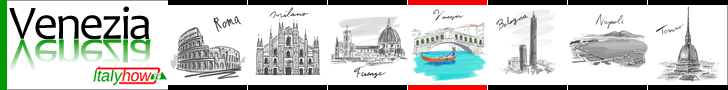Fratello Sole, Sorella Luna: la Natura nell'Arte
- Pubblicato in Perugia
- 0 commenti
La Galleria Nazionale dell'Umbria di Perugia ospita dal 15 marzo al 15 giugno 2025 la straordinaria mostra "Fratello Sole, Sorella Luna. La Natura nell'Arte, tra Beato Angelico, Leonardo e Corot". L'esposizione, curata da Costantino D'Orazio, direttore dei Musei Nazionali di Perugia, insieme a Veruska Picchiarelli e Carla Scagliosi, storiche dell'arte responsabili delle collezioni della Galleria, celebra l'ottavo centenario dalla composizione del "Cantico delle Creature" di San Francesco d'Assisi, uno dei primi testi poetici in lingua volgare e manifesto di un rapporto rinnovato con la Natura.
La mostra, che ha già registrato oltre 5.000 prenotazioni prima dell'apertura, è stata inserita nel calendario ufficiale del Giubileo 2025 dal Dicastero per l'Evangelizzazione della Santa Sede, e gode del patrocinio della Regione Umbria e del Comune di Perugia. L'esposizione ha ottenuto inoltre il sostegno del Comitato per le celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi e il contributo della Fondazione Perugia.
Il percorso espositivo presenta oltre ottanta capolavori tra dipinti, disegni, incisioni, sculture e volumi a stampa, provenienti dai più prestigiosi musei italiani e internazionali, tra cui il Louvre di Parigi, il Rijksmuseum e il Mauritshuis di Amsterdam, i Musei Vaticani e numerose istituzioni culturali italiane. L'obiettivo è raccontare l'evoluzione del rapporto tra l'uomo e la Natura attraverso le opere di alcuni tra gli artisti più celebri della storia dell'arte: Pisanello, Michelino da Besozzo, Paolo Uccello, Jan van Eyck, Beato Angelico, Piero della Francesca, Leonardo da Vinci, Leon Battista Alberti, Albrecht Dürer, Lorenzo Lotto, Dosso Dossi, Giambologna, Jan Brueghel il Vecchio, Domenichino, Annibale Carracci, Nicolas Poussin, Salvator Rosa, Giambattista Piranesi e Jean-Baptiste Camille Corot, solo per citarne alcuni.
I capolavori in mostra
Ad aprire il percorso espositivo è il formidabile "Giudizio Universale" del Beato Angelico, prestito eccezionale dal Museo di San Marco di Firenze, mentre dalla Galleria dell'Accademia di Firenze giunge l'enigmatica "Tebaide" di Paolo Uccello, presente in mostra anche con la "Predella con il Miracolo dell'Ostia profanata" dalla Galleria Nazionale delle Marche di Urbino.
Le Gallerie dell'Accademia di Venezia hanno concesso il celebre "San Girolamo" di Piero della Francesca, posto in dialogo con la "Crocifissione" di Jan van Eyck della Galleria Franchetti alla Ca' d'Oro e con il "San Girolamo" dipinto da Lorenzo Lotto, proveniente da Castel Sant'Angelo a Roma.
Il Museo del Louvre di Parigi ha inviato a Perugia quattro preziosi disegni di Pisanello, capaci di restituire l'attenzione naturalistica di questo grande interprete del gotico internazionale, pioniere dell'osservazione scientifica della natura.
Tra i manoscritti più significativi presenti in mostra figurano gli straordinari volumi miniati provenienti dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma: la "Legenda maior sancti Francisci" di Bonaventura da Bagnoregio, realizzata dal Maestro della Legenda Maior (attivo a Milano, 1340-1350 circa), e la "Bibbia" del 1399, opera di miniatori padovani attivi a Padova o Vicenza intorno al 1400.
La "Madonna del Roseto" di Michelino da Besozzo rappresenta un'iconica raffigurazione della natura idealizzata nella sua perfezione, illustrando la cultura figurativa tardogotica. In contrapposizione, testimoni del pieno Umanesimo, sono esposti volumi fondamentali come il "De Pictura" di Leon Battista Alberti, la "Summa de arithmetica" di Luca Pacioli e il "De Prospectiva pingendi" di Piero della Francesca, che segnano un'epocale rivoluzione nella rappresentazione dello spazio naturale attraverso il sistema prospettico.
Un'attenzione particolare è dedicata al "Codice Atlantico" di Leonardo da Vinci, di cui la Biblioteca Ambrosiana di Milano ha prestato due fogli che documentano gli studi sul volo degli uccelli, sia attraverso l'osservazione diretta della natura sia mediante la progettazione di macchine ispirate agli uccelli.
L'"Hypnerotomachia Poliphili" di Francesco Colonna introduce il tema del valore simbolico degli elementi naturali, esplorato anche da pittori come Dosso Dossi, con la "Melissa" dalla Galleria Borghese, Federico Barocci, autore di una commovente rappresentazione delle "Stimmate di San Francesco" proveniente da Fossombrone, e Correggio, di cui è esposto il "Ritratto di uomo che legge" del Castello Sforzesco di Milano.
Il percorso prosegue con la visione idealizzata della natura attraverso i campioni della pittura classicista e barocca, da Annibale Carracci, con la "Visione di Sant'Eustachio", a Giovanni Lanfranco, con l'"Assunzione della Maddalena" dal Museo di Capodimonte di Napoli. L'avvento di un approccio moderno alle scienze naturali è evidenziato nel passaggio dalle raccolte delle Wunderkammern alle pubblicazioni di Ulisse Aldrovandi, mentre le scoperte scientifiche e astronomiche di inizio Seicento sono rappresentate dal manoscritto del "Sidereus Nuncius" di Galileo Galilei della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
Particolarmente ricca è la sezione dedicata alla natura misteriosa e incombente nei paesaggi tra Seicento e Ottocento, con opere di Nicolas Poussin, William Hamilton, Donato Creti (due prestiti eccezionali dai Musei Vaticani), Claude Lorrain e Giambattista Piranesi. La mostra si chiude con la "Cascata delle Marmore" dipinta da Jean-Baptiste Camille Corot, celebre meta del Grand Tour nell'Ottocento.
Le sezioni della mostra
Il percorso espositivo si articola in cinque sezioni tematiche che esplorano diverse concezioni della Natura nella storia dell'arte:
1. La Natura madre
Questa sezione si concentra sulla trasformazione culturale avvenuta tra il XII e il XIII secolo, quando gli artisti iniziarono a guardare con occhio nuovo alla realtà, cercando di coglierne le specificità. Si affermano temi iconografici in cui la natura è descritta nelle vesti di una madre generosa, come i cicli dei Mesi, che associano lo scorrere delle stagioni al lavoro umano. La tendenza all'astrazione simbolica viene gradualmente sostituita da un approccio analitico sempre più consapevole, che matura in epoca tardogotica, quando l'arte diviene vero e proprio strumento di conoscenza della natura.
2. La Natura impossibile
La civiltà tardogotica insegue "il sogno di una vita più bella" e l'arte dà vita a una natura "favolosa", impossibile nella sua perfezione. In chiave sacra il tema è interpretato come hortus conclusus, di cui è emblema la "Madonna del roseto" di Michelino da Besozzo, o come Giardino del Paradiso, sfolgorante nel "Giudizio Universale" di Beato Angelico. L'Hypnerotomachia Poliphili sancisce in pieno Umanesimo la riconciliazione definitiva dell'uomo con il mondo sensibile, in un percorso che è metafora del viaggio immaginario in mondi di pura invenzione.
3. La Natura come spazio dell'uomo
In contrapposizione all'arte medievale, il realismo di Giotto, basato sull'esperienza empirica, si prefigge uno scopo illusionistico, dando figurativamente corpo agli elementi del creato. La prospettiva lineare a punto di fuga centrale, teorizzata nel Quattrocento, apre le porte all'arte del Rinascimento, vivificata anche dall'approccio lenticolare alla realtà dell'arte fiamminga. Parallelamente, la curiosità scientifica nei confronti del mondo naturale porta Leonardo da Vinci all'elaborazione della prospettiva aerea e dello sfumato. Il Seicento vede l'affermarsi del paesaggio come genere autonomo, riconoscendo alla rappresentazione un valore scientifico e un fine conoscitivo.
4. La Natura mirabile
Sul calare del Medioevo inizia il cammino delle discipline scientifiche moderne e si sviluppa un'attitudine all'osservazione acuta e alla trasposizione oggettiva delle forme della natura. Si afferma la pratica di studiare "dal vero" piante e animali, che tocca vertici assoluti nel corpus grafico di Pisanello. La meraviglia e la curiosità sono i criteri che informano le Wunderkammern, microcosmi che vogliono abbracciare tutto il visibile e il conoscibile. Parallelamente si fa strada un approccio scientifico al dato naturale, evidente nei fogli di Leonardo dedicati al volo degli uccelli e nelle pubblicazioni di Ulisse Aldrovandi, che segnano l'inizio dell'atteggiamento delle moderne scienze naturali verso una sistematica catalogazione delle specie.
5. La Natura incombente
Al cospetto delle manifestazioni naturali più spettacolari o impetuose, l'uomo ha da sempre provato un senso di smarrimento o di terrore. Paesaggi raffiguranti una natura selvaggia o ostile sono già presenti nella pittura del XVI secolo, come dimostrano le opere di Lorenzo Lotto e Paul Bril. Nel corso del Settecento e dell'Ottocento, le forze indomabili che governano il creato diventano protagoniste delle speculazioni filosofiche sul Sublime, definito da Edmund Burke "un piacevole terrore". La sensibilità settecentesca e le inquietudini romantiche sceglieranno cascate, tempeste, cieli plumbei, burrasche, naufragi ed eruzioni vulcaniche come soggetti privilegiati, dove il paesaggio diventa cassa di risonanza delle emozioni umane e manifestazione visibile dell'Infinito.
La sala immersiva e le iniziative collaterali
Con la mostra "Fratello Sole, Sorella Luna" inaugura la sala immersiva permanente della Galleria Nazionale dell'Umbria, uno spazio che offre ai visitatori un'esperienza ogni volta diversa grazie all'uso delle nuove tecnologie. Per l'occasione, al centro dell'installazione è stato posto il "Cantico delle Creature", che fa da guida per la scoperta dei dettagli delle opere d'arte, nel tentativo di riscoprire il senso di questo capolavoro della letteratura: una preghiera e un'ode alla sublime bellezza della Natura.
La mostra sarà accompagnata da diverse iniziative collaterali, tra cui una serie di incontri organizzati in collaborazione con l'Assessorato all'Ambiente del Comune di Perugia, che affronteranno temi come "Foresta e Società", "Consumo di suolo e la rappresentazione del dato" e "Costruire la Natura in Città: i servizi ecosistemici del verde urbano". Domenica 13 aprile, l'Ufficio Servizi Educativi della Galleria organizzerà la giornata per le famiglie dal titolo "Marrone. Foreste di cartone" nell'ambito del progetto "Tutti i colori della GNU".
Un catalogo edito da Moebius (Milano) accompagna l'esposizione, con testi introduttivi delle autorità, saggi dei curatori e di numerosi studiosi, oltre alle schede delle opere redatte da specialisti e accademici afferenti a istituti culturali di tutta Italia.
Informazioni pratiche:
Fratello Sole, Sorella Luna. La Natura nell'Arte, tra Beato Angelico, Leonardo e Corot
Perugia, Galleria Nazionale dell'Umbria (corso Pietro Vannucci, 19)
15 marzo - 15 giugno 2025
Orari: dal lunedì alla domenica 08.30-19.30 (ultimo ingresso 18.30)
Biglietti: intero €12.00; ridotto €2.00; gratuito per i possessori della card GNU e per gli aventi diritto.
Il biglietto include anche la visita alla Galleria Nazionale dell'Umbria.
- Data inizio: Sabato, 15 Marzo 2025
- Data fine: Mercoledì, 04 Giugno 2025
- Evento a pagamento: Sì
Galleria immagini
-
 Lorenzo Monaco, Crocifissione
Lorenzo Monaco, Crocifissione
Lorenzo Monaco, Crocifissione
Lorenzo Monaco, Crocifissione
-
 Piero della Francesca, San Girolamo e donatore, 1460-1465
Piero della Francesca, San Girolamo e donatore, 1460-1465
Piero della Francesca, San Girolamo e donatore, 1460-1465
Piero della Francesca, San Girolamo e donatore, 1460-1465
-
 Paolo Uccello, Miracolo dell’Ostia profanata, 1567-1568
Paolo Uccello, Miracolo dell’Ostia profanata, 1567-1568
Paolo Uccello, Miracolo dell’Ostia profanata, 1567-1568
Paolo Uccello, Miracolo dell’Ostia profanata, 1567-1568
-
 Jan van Eyck e bottega, Crocifissione, prima metà XV secolo
Jan van Eyck e bottega, Crocifissione, prima metà XV secolo
Jan van Eyck e bottega, Crocifissione, prima metà XV secolo
Jan van Eyck e bottega, Crocifissione, prima metà XV secolo
-
 Beato Angelico, Giudizio Universale, 1425-1430
Beato Angelico, Giudizio Universale, 1425-1430
Beato Angelico, Giudizio Universale, 1425-1430
Beato Angelico, Giudizio Universale, 1425-1430
-
 Lorenzo Lotto, San Girolamo penitente, 1509
Lorenzo Lotto, San Girolamo penitente, 1509
Lorenzo Lotto, San Girolamo penitente, 1509
Lorenzo Lotto, San Girolamo penitente, 1509
-
 Jean De Boulogne detto Giambologna, Aquila, 1567 – 1568
Jean De Boulogne detto Giambologna, Aquila, 1567 – 1568
Jean De Boulogne detto Giambologna, Aquila, 1567 – 1568
Jean De Boulogne detto Giambologna, Aquila, 1567 – 1568
-
 Jean Baptiste Camille Corot, La Cascata delle Marmore a Terni,...
Jean Baptiste Camille Corot, La Cascata delle Marmore a Terni,...
Jean Baptiste Camille Corot, La Cascata delle Marmore a Terni,...
Jean Baptiste Camille Corot, La Cascata delle Marmore a Terni,...
-
 Galileo Galilei, Astronomia. Osservazioni delle fasi lunari, novembre-dicembre 1609
Galileo Galilei, Astronomia. Osservazioni delle fasi lunari, novembre-dicembre 1609
Galileo Galilei, Astronomia. Osservazioni delle fasi lunari, novembre-dicembre 1609
Galileo Galilei, Astronomia. Osservazioni delle fasi lunari, novembre-dicembre 1609
-
 Giovanni Battista Piranesi, Vedute Di Roma, Veduta delle Cascatelle a...
Giovanni Battista Piranesi, Vedute Di Roma, Veduta delle Cascatelle a...
Giovanni Battista Piranesi, Vedute Di Roma, Veduta delle Cascatelle a...
Giovanni Battista Piranesi, Vedute Di Roma, Veduta delle Cascatelle a...
-
 Polidoro Caldara da Caravaggio, Sant’Alberto Carmelitano, 1530-1535
Polidoro Caldara da Caravaggio, Sant’Alberto Carmelitano, 1530-1535
Polidoro Caldara da Caravaggio, Sant’Alberto Carmelitano, 1530-1535
Polidoro Caldara da Caravaggio, Sant’Alberto Carmelitano, 1530-1535
-
 Giovanni Luteri detto Dosso Dossi, Melissa, 1518 circa
Giovanni Luteri detto Dosso Dossi, Melissa, 1518 circa
Giovanni Luteri detto Dosso Dossi, Melissa, 1518 circa
Giovanni Luteri detto Dosso Dossi, Melissa, 1518 circa
-
 Salvator Rosa, Marina con faro, 1635-1636
Salvator Rosa, Marina con faro, 1635-1636
Salvator Rosa, Marina con faro, 1635-1636
Salvator Rosa, Marina con faro, 1635-1636
-
 Giacinto Gigante, Penisola sorrentina al tramonto, 1850 circa
Giacinto Gigante, Penisola sorrentina al tramonto, 1850 circa
Giacinto Gigante, Penisola sorrentina al tramonto, 1850 circa
Giacinto Gigante, Penisola sorrentina al tramonto, 1850 circa
-
 Jacob Isaackszoon van Ruisdael, Paesaggio con dune e ruscello, 1646-1647...
Jacob Isaackszoon van Ruisdael, Paesaggio con dune e ruscello, 1646-1647...
Jacob Isaackszoon van Ruisdael, Paesaggio con dune e ruscello, 1646-1647...
Jacob Isaackszoon van Ruisdael, Paesaggio con dune e ruscello, 1646-1647...
-
 "Fratello sole, sorella luna"
"Fratello sole, sorella luna"
"Fratello sole, sorella luna"
"Fratello sole, sorella luna"
-
 "Fratello sole, sorella luna"
"Fratello sole, sorella luna"
"Fratello sole, sorella luna"
"Fratello sole, sorella luna"
-
 "Fratello sole, sorella luna"
"Fratello sole, sorella luna"
"Fratello sole, sorella luna"
"Fratello sole, sorella luna"
-
 "Fratello sole, sorella luna"
"Fratello sole, sorella luna"
"Fratello sole, sorella luna"
"Fratello sole, sorella luna"
-
 "Fratello sole, sorella luna"
"Fratello sole, sorella luna"
"Fratello sole, sorella luna"
"Fratello sole, sorella luna"
https://www.italyhowto.com/perugia/2755-fratello-sole-sorella-luna-la-natura-nell-arte.html#sigProGalleria74b1c57611